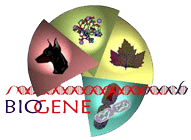Ancora una volta BioGene è stato il primo laboratorio in Italia a scegliere i contaglobuli Sysmex; oggi, a distanza di 10 anni, la tecnologia Sysmex è diventata punto di riferimento nell’ematologia veterinaria e marchio di punta. Oggi, il laboratorio è già in grado di offrire nelle routine, anche l’ultimo upgrade disponibile sulle proprie macchine ovvero la lettura in fluorescenza dei reticolociti e delle piastrine soddisfacendo le esigenze dei clinici rendendo anche queste informazioni fondamentali, immediatamente riscontrabili nel referto emocromocitometrico.
Nuovi upgrade in ematologia.
Grazie a Sysmex, il laboratorio BioGene ha introdotto:
– nuovi parametri nella analisi delle piastrine, ora lette in fluorescenza, permettendo di determinare la “Immature Plated Fraction” utile nella classificazione delle piastrinopenie (rigenerative, croniche, centrali o periferiche) oltre a fornire una conta più sensibile ed accurata;
– la possibilità di avere finalmente una conta automatica a 10 parametri + formula leucocitaria per pesci, rettili ed uccelli in pochi secondi.
Anticipatori nelle scelte, sostenute e validate oggi da quanto prodotto in ambito scentifico
(- Alejandro Perez-Ecija, Carmen Martinez,
Julio Fernandez-Castañer, Francisco J. Mendoza
Utility of immature platelet fraction in the Sysmex XN-1000V for the
differential diagnosis of central and peripheral thrombocytopenia in dogs and
cats.
DOI: 10.1111/jvim.17074 – Journal of Veterinay Internal Medicine. 2024 May-Jun;38(3):1512-1519.
– Perez-Ecija A, Martinez C, Fernandez-Castañer J, Mendoza FJ. The Immature Reticulocyte Fraction (IRF) in the Sysmex XN-1000V Analyzer Can Differentiate between Causes of Regenerative and Non-Regenerative Anemia in Dogs and Cats. Animals (Basel). 2024 Jan 22;14(2):349.
– Guerlin M, Granat F, Grebert M, Braun JP, Geffré A, Bourgès-Abella N, Trumel C. Validation of the Sysmex XN-V hematology analyzer for feline specimens. Vet Clin Pathol. 2024 Sep;53(3):294-308.
– Ginders J, Stirn M, Novacco M, Hofmann-Lehmann R, Riond B. Validation of the Sysmex XN-V Automated Nucleated Red Blood Cell Enumeration for Canine and Feline EDTA-Anticoagulated Blood. Animals (Basel). 2024 Jan 30;14(3):455.
– Jornet-Rius O, Mesalles-Naranjo M, Pastor J. Performance of the Sysmex XN-V hematology analyzer in determining the immature platelet fraction in dogs: A preliminary study and reference values. Vet Clin Pathol. 2023 Sep;52(3):433-442.
– Grebert M, Granat F, Braun JP, Leroy Q, Bourgès-Abella N, Trumel C. Validation of the Sysmex XN-V hematology analyzer for canine specimens. Vet Clin Pathol. 2021 Jun;50(2):184-197.)
Siamo infatti lieti di rappresentarVi le informazioni introdotte con i nuovi parametri disponibili:
RET: percentuale e numero assoluto di reticolociti totali;
H-RET: percentuale di reticolociti ad alta fluorescenza (immaturi);
M-RET: percentuale di reticolociti a fluorescenza media (moderatamente immaturi);
L-RET: percentuale di reticolociti a bassa fluorescenza (quasi maturi);
IRF: valore globale di reticolociti immaturi;
Ret-He: contenuto emoglobinico reticolocitario;
RPI: indice di produzione reticolocitaria;
P-LCR: large platelets;
IPF: frazione piastrinica immatura
Si ricorda che a completamento delle misurazioni strumentali, il referto si accompagna sempre alla verifica-commento dello striscio ematico al microscopio che segnala eventuali anomalie morfologiche cellulari nonché altri eventuali reperti patologici riscontrati.